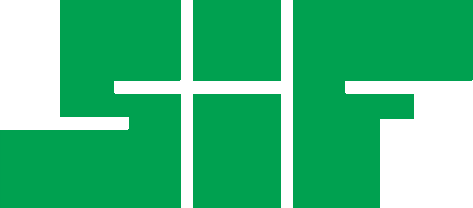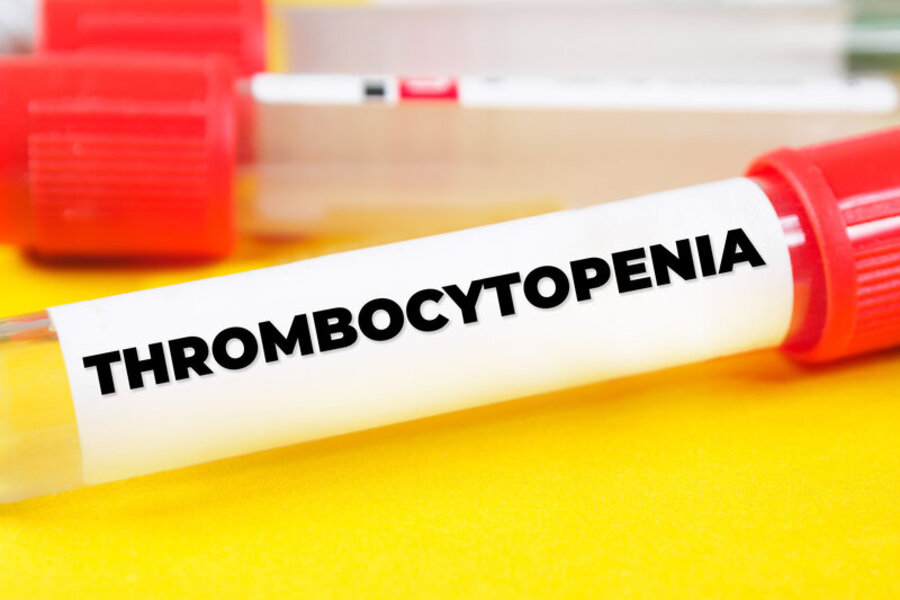Che cosa si intende per Farmacologia di Genere e perché dovrebbe interessarci? La Farmacologia di Genere è quella parte della Farmacologia che studia l’influenza delle differenze biologiche e delle differenze culturali e socio-economiche sull’effetto dei farmaci in ogni persona, sia in termini di efficacia (cioè se ha effetti terapeutici) che di sicurezza (cioè se ha effetti avversi e di che tipo). Ormai sappiamo che, in molti casi, il tipo e la dose di un farmaco prescritto per una data malattia devono essere diversi in funzione non solo del sesso ma anche delle differenze culturali e socio-economiche (genere) presenti tra donne e uomini nella nostra società. Queste conoscenze faticano, però, ad essere utilizzate in clinica. Precisamente, che differenza c’è tra genere e sesso? Per sesso di un essere umano intendiamo il suo essere maschio, femmina o transgender e questo determina differenze biologiche importanti nella risposta ad un farmaco. Il genere definisce l’impatto dei determinanti socio-economici e le aspettative culturali socialmente costruite, associate all’essere maschio, femmina o transgender. Anche queste differenze influiscono sugli effetti di un farmaco. Ad esempio, una donna è, di solito, una femmina (sesso) che fa determinate esperienze e che è cresciuta in una determinata società (che tende a considerare diversamente femmine e maschi). Ciò fa in modo che la cultura della donna sia diversa da quella dell’uomo. Ad esempio, è noto che la percezione del dolore tra donne e uomini è diversa. Inoltre, è possibile che, almeno in certe zone del nostro Paese, essere uomo o donna comporti essere occupati in lavori diversi ed un reddito diverso. Tutto ciò può influenzare la risposta ai farmaci. Al di là delle apparenze, ci spiega perchè una femmina è profondamente diversa da un maschio (e viceversa)? Elencare tutte le differenze non è possibile. Se rimaniamo nel campo della Farmacologia, sicuramente differenze importanti da considerare sono rappresentate dal peso, dalla composizione corporea, dall’acidità gastrica, dal tempo di svuotamento gastrico, dalla massa muscolare, dalla funzionalità renale, dai diversi ormoni e dalle variazioni ormonali. Sono questi solo alcuni dei fattori che influenzano sia l’assorbimento che l’efficacia e la tossicità dei farmaci. Perchè queste differenze possono incidere sulla dose e il tipo di farmaci che una paziente femmina deve assumere rispetto ad un paziente maschio? A causa di un arruolamento insufficiente di donne e di transgender in tutte le varie fasi della sperimentazione, soprattutto negli studi di fase 1 che valutano la dose massima tollerata, le dosi vengono definite principalmente sul peso dell’individuo maschio. In aggiunta, durante la sperimentazione, raramente si tiene conto delle differenze derivanti dalla complessità della vita riproduttiva della donna, come ad esempio la gravidanza o l’allattamento, nonché, nella donna fertile, del ciclo mensile o, nella donna in menopausa, della terapia ormonale sostitutiva. Come mai è rarissimo trovare dosaggi diversi per maschi e femmine? Insomma, come mai scopriamo l’importanza di queste differenze solo in questi anni? Fino al 1993, l’esclusione delle donne dalla sperimentazione dei farmaci aveva lo scopo di “proteggerle”, soprattutto nei confronti di possibili gravidanze, per eventuale insorgenza di effetti teratogeni (malformazioni del feto) con compromissione della salute del feto. Oggi, permane l’assenza di un corretto e bilanciato arruolamento di donne, uomini e/o transgender negli studi clinici sperimentali perché ciò rende questi studi molto più complessi e molto più costosi. Sarebbe necessario identificare, ad esempio, sottogruppi del mondo femminile (età fertile, gravidanza, menopausa etc.) che andrebbero studiati ed analizzati in maniera specifica. Tutto ciò porta ad una mancanza nell’equità di cura. In particolare, dato che il gruppo più studiato è quello dei maschi, i gruppi meno studiati (femmine e transgender) possono essere danneggiati dalle scelte che vengono fatte sulla base di questi studi. Può fare un esempio di farmaco che è più utile in un maschio e meno utile in una femmina? Faccio due esempi. Il primo potrebbe essere rappresentato dal propofol, un anestetico utilizzato per l’induzione e il mantenimento dell’anestesia generale. Diversi studi hanno dimostrato che gli uomini sono più sensibili alla sua azione, pertanto la dose prevista dovrebbe essere ridotta del 30-40% rispetto al dosaggio utilizzato nel sesso femminile. Come secondo esempio cito l’ibuprofene, un antiinfiammatorio non steroideo utilizzato su larga scala. A parità di concentrazioni plasmatiche (quanto ce n’è nel sangue), risulta essere più efficace negli uomini. E viceversa? Anche qui riporto due esempi. Le donne sembrano rispondere meglio degli uomini agli antidepressivi inibitori selettivi della serotonina (ad esempio, fluoxetina, paroxetina e sertralina) rispetto agli antidepressivi triciclici (ad esempio, amitriptilina). L’altro caso potrebbe essere rappresentato dalla morfina, un farmaco utilizzato nel trattamento del dolore di entità da moderata a grave. È stato dimostrato che la morfina possiede una maggiore efficacia sulle donne. Può fare un esempio di farmaco che dà effetti avversi diversi in maschi e femmine? Posso citare i diuretici. Nel sesso femminile, provocano prevalentemente iponatriemia (bassi livelli di sodio nel sangue), mentre negli uomini producono una riduzione del volume plasmatico (quantità di sangue). Un altro esempio è costituito dai farmaci antidiabetici appartenenti alla classe dei tiazolidindioni, utilizzati dai pazienti con diabete di tipo 2. Essi inducono un aumento delle fratture ossee nelle pazienti diabetiche, meno pronunciato negli uomini. Inoltre, quando trattati con antipsicotici (farmaci utilizzati, ad esempio, per curare la schizofrenia), si osserva una maggiore incidenza di discinesie (movimenti involontari) tardive in pazienti anziani maschi. La severità risulta però maggiore nel sesso femminile in tarda età. La pandemia COVID-19 che stiamo vivendo ha mostrato una chiara differenza di genere negli esiti sanitari come ricovero e decesso. Si è cercato di affrontare il virus anche in un’ottica di genere? Purtroppo no. E devo dire che stiamo perdendo un’occasione. Sebbene siano state testate più opzioni farmacologiche tra cui anticoagulanti, glucocorticoidi, antivirali, agenti antinfiammatori per trattare i pazienti con COVID-19 con vari livelli di evidenza in termini di efficacia e sicurezza, le informazioni sulle strategie di trattamento in ottica di genere sono attualmente molto limitate. Alcuni componenti del Gruppo di Lavoro sulla Farmacologia di Genere hanno recentemente analizzato il fenomeno. Purtroppo, anche in questo caso, nonostante l'enorme quantità di protocolli clinici avviati e sebbene fossero considerati arruolabili negli studi maschi, femmine e transgender, non sono state previste analisi di genere specifiche in termini di differenze di sicurezza o efficacia dei farmaci nella gran parte dei protocolli sperimentali. Che cosa state facendo per cambiare la situazione attuale? All’interno del Gruppo di Lavoro della SIF abbiamo avviato alcuni progetti il cui obbiettivo iniziale è quello di diffondere la cultura della Farmacologia di Genere partendo dall’interno dei nostri laboratori di ricerca. Ad esempio, stiamo cercando di preparare delle linee guida a cui possa far riferimento chiunque si approcci allo studio della Farmacologia di Genere, partendo dall’utilizzo delle linee cellulari e degli animali da sperimentazione. Difatti, molto spesso chi fa ricerca di genere si trova di fronte ad aspetti metodologici molto differenti tra laboratori. Per cui vorremmo cercare di affrontare il problema alla radice, armonizzando e rendendo uniformi le procedure sperimentali. All’interno del Gruppo di Lavoro, altri colleghi si stanno occupando della problematica di genere nella ricerca clinica, considerando le singole aree terapeutiche. Il momento è particolarmente propizio se consideriamo che uno degli obbiettivi più importanti nel programma Horizon Europe (un grande progetto finanziato dall’Europa) è proprio la "Gender Equality", declinata in ogni suo aspetto, compresa la Gender Pharmacology.
Profilo di Luigia Trabace
Luigia Trabace, Professore Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia. Ha condotto parte delle sue ricerche presso il Department of Cognitive and Molecular Neuroscience, The Babraham Institute, Babraham, Cambridge, UK e presso il Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano. Coordina il Gruppo di Lavoro di Farmacologia di Genere della Società Italiana di Farmacologia. Svolge le proprie ricerche nei settori della farmacologia di genere, della neurofarmacologia di patologie a carattere neurodegenerativo e psichiatrico, della modulazione farmacologica di sistemi neurotrasmettitoriali da parte di sostanze naturali, e del doping in collaborazione con laboratori italiani e stranieri.