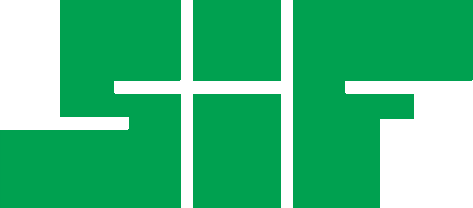Professore Associato, Dipartimento di Farmacia & Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari. I suoi temi di interesse sono la Farmacologia preclinica e traslazionale, lo Studio dei farmaci mediante metodiche biofisiche e di biologia molecolare in situazioni fisiologiche (sviluppo e invecchiamento, disuso, cachessia) e patologiche (malattie metaboliche, canalopatie, malattie rare, sindromi miotoniche, SLA). È autrice di 90 pubblicazioni scientifiche su riviste ad alto fattore di impatto.
Si tratta di malattie tropicali che colpiscono milioni di persone, soprattutto nelle regioni più povere del mondo. Alcune di queste malattie si stanno diffondendo anche in Italia. Purtroppo, le terapie sono scarse e la prevenzione gioca un ruolo cruciale.
L’aumento dei livelli dei trigliceridi nel sangue può portare a gravi conseguenze, come l’insorgenza di eventi cardiovascolari e di pancreatite. I fibrati sono i farmaci più comunemente usati per trattare questa condizione patologica ma ci sono novità in arrivo.
Nella scorsa stagione invernale, l’amoxicillina è stata tra i farmaci introvabili. Vediamo perché questo farmaco è così importante e perché lo utilizziamo. L’amoxicillina serve a curare le infezioni sostenute dai batteri sensibili a questo farmaco.
Il microbiota intestinale è un alleato per la nostra salute. Ma cosa succede se un evento occasionale ne altera la composizione? Può contribuire ad incrementare o causare alcune patologie? Si può intervenire con farmaci o altri prodotti? Abbiamo rivolto queste domande ad alcuni esperti nel settore, i professori Giuseppe Esposito, Università La Sapienza, Sebastiano Alfio Torrisi, Università di Catania, Annamaria Cattaneo, Università di Milano e Giuseppina Mattace Raso, Università di Napoli.
La ricerca clinica comprende tutti gli studi condotti nell’uomo per valutare l’efficacia e la sicurezza di nuovi farmaci, dispositivi medici, metodi diagnostici, con il fine di identificare nuove e migliori opportunità di assistenza e cura. Questi studi sono necessari affinché una nuova molecola possa essere commercializzata ma possono avere un ruolo anche dopo il suo ingresso sul mercato. La pandemia scatenata dal virus SARS-CoV-2 ha mostrato le debolezze intrinseche e la farraginosità del “vecchio” modello di studi clinici e accelerato un’iniziativa europea che ha lo scopo di “trasformare” gli studi clinici: le parole chiave sono semplificazione e digitalizzazione.
L’olio di bergamotto si ricava dal frutto che cresce su una pianta denominata Citrus Bergamia molto diffusa nelle zone del mediterraneo e in Italia in particolare in Calabria, dove il Bergamotto di Reggio Calabria ha ricevuto anche la denominazione DOP di origine protetta. L’olio di bergamotto è utilizzato nell’aromaterapia per migliorare l’umore e i sintomi dello stress che si osservano nell’ansia, depressione, disturbi comportamentali della demenza, e nel dolore cronico in virtù delle sue proprietà analgesiche utili durante i processi infiammatori e nel dolore neuropatico. Grazie ai risultati di studi preclinici ed agli studi clinici attualmente in corso di svolgimento, oggi ci sono nuove prospettive per il suo impiego nell’uomo.
La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva ancora incurabile, con esito infausto, che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule del sistema nervoso che attraverso i loro prolungamenti inviano segnali dal cervello al midollo spinale e da qui ai muscoli, controllando quindi il movimento. Nella SLA i motoneuroni vanno incontro a perdita di funzione e i muscoli perdono forza (atonia) e massa (atrofia) fino alla paralisi. Il danno ai muscoli è progressivo e la morte di solito sopravviene per paralisi dei muscoli respiratori. La terapia per questa malattia è ancora carente e la ricerca è tutt’ora in corso con trial clinici per testare efficacia e sicurezza di nuovi farmaci e di terapie biologiche avanzate.
L’idrossiclorochina (HCQ) è stata proposta con lo scopo principale di prevenire le complicanze della CoViD-19. Ma funziona questo farmaco e, se si, quanto? Dipende dal tipo di paziente o dalla dose somministrata? L’esame degli studi che l’hanno utilizzata permette di dimostrare una efficacia certa?
La frequenza della malattia di Kawasaki nella forma più o meno tipica è aumentata notevolmente negli ultimi mesi, in concomitanza con la COVID-19. Oggi, dati scientifici più recenti permettono di rivedere il principio enunciato che vi sia una correlazione ed una responsabilità della COVID-19 nello stimolare la malattia di Kawasaki (1).
Il gabesato, un farmaco in grado di ridurre la produzione di citochine infiammatorie e usato per la pancreatite acuta e la coagulazione intravascolare disseminata, può rappresentare uno strumento importante per trattare i pazienti affetti da COVID-19 agendo su tre bersagli contemporaneamente.
I malati rari sono più vulnerabili. Quali sono le strategie farmacologiche da mantenere o da usare con cautela nelle malattie rare non oncologiche?