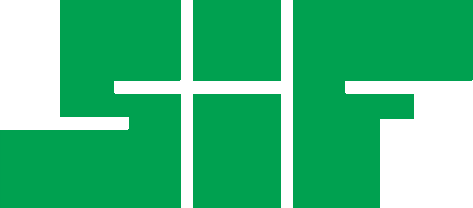Cosa succede quando si prova dolore?
La percezione del dolore avviene a carico di alcuni sensori, chiamati nocicettori che, in presenza dello stimolo doloroso, ad esempio una fonte di calore, mandano delle informazioni specifiche ad un gruppo di neuroni che si trovano nel midollo spinale.
Da qui, le informazioni raccolte vengono trasmesse in aree specifiche del nostro cervello che provvedono ad elaborare la sensazione del dolore (quale zona del corpo è coinvolta? Il dolore è poco o molto intenso?), a compiere le azioni necessarie per rimuoverne l’origine (la mano si retrae) e ad associare l’evento doloroso a una determinata sensazione, permettendo ad esempio l’apprendimento che quello stimolo va evitato, come nel caso dei bambini che imparano a non giocare con il fuoco.
Inoltre, durante la percezione del dolore, viene stimolato un sistema di controllo che limita (spegne) la percezione dolorosa stessa. Quando l’evento che ha scatenato la risposta viene interrotto (l’esposizione alla fonte di calore), questo sistema si attiva e a poco a poco, se il danno prodotto è stato di lieve entità, la sensazione di dolore scompare.
Il dolore può diventare una patologia?
A volte sì, perché qualcosa può non andare per il verso giusto. Infatti, in alcuni casi l’evento scatenante il dolore non può essere evitato, ad esempio dopo una brutta frattura, mentre altre volte non lo si può arginare facilmente, come nel caso di un cancro che cresce.
Altre volte non si riesce ad identificare l’origine del dolore: può capitare che i nocicettori, cioè i sistemi che percepiscono il dolore, diventino molto più sensibili a degli stimoli che normalmente non dovrebbero dare una risposta dolorifica (nel gergo scientifico si chiama allodinia), o che i sistemi di trasmissione dell’informazione del dolore non funzionino bene.
Può avvenire infatti quel processo chiamato maladattamento, in cui si creano delle connessioni errate tra i neuroni che trasmettono e quelli che bloccano la percezione dolorosa, evento alla base del dolore neuropatico cronico.
Se il dolore è qualcosa di normale e fisiologico, perché c’è bisogno di affermare che la terapia del dolore è un diritto1 ?
La ragione principale a sostegno del diritto alla terapia del dolore sta nel fatto che la medicina ha permesso di superare la considerazione che la sopportazione del dolore fisico sia una virtù. Il dolore, quello intenso e cronico lede la dignità umana. Questa è la base etica e legale che, in Italia, stabilisce il diritto di accesso alla terapia del dolore sancito dalla Legge.
Tale legge, del 15 marzo 2010 n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Le basi di questa legge derivano dalla considerazione che il dolore, anche se spesso è una risposta fisiologica o para-fisiologica, è tra le sensazioni più spiacevoli e può raggiungere livelli insopportabili ed invalidanti che ledono la dignità dell’individuo. La legge quindi “garantisce l’accesso alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana”.
Ma allora perché l’accesso alla terapia del dolore è controllato in modo così severo2 ?
C’è una ragione di base ed è dovuta alle caratteristiche dei farmaci utilizzati per il controllo del dolore.
Naturalmente non parliamo dei farmaci che normalmente usiamo per trattare dolori accidentali come il mal di denti, il dolore dovuto alla martellata sul pollice mentre si appende un quadro alla parete o la sbucciatura di un ginocchio per la caduta dalla bicicletta, casi in cui i farmaci tipici sono dei potenti antiinfiammatori con abilità antidolorifiche (ad esempio il naprossene, l’ibuprofene o l’acido acetilsalicilico).
I farmaci di cui parleremo sono quelli indicati per i dolori gravosi, continui, duraturi nel tempo come quelli di origine tumorale, le emicranie, i dolori addominali e, più in generale, i dolori di origine neuropatica.
Questi farmaci, spesso identificati come analgesici maggiori, sono gli antidolorifici più efficaci e potenti che si conoscano; sono i cosiddetti oppioidi (farmaci come la morfina e il fentanyl), sostanze che possono dare tolleranza, dipendenza e, in caso di overdose (cioè di autosomministrazione di dosi superiori a quelle tollerate dall’organismo), effetti indesiderati gravi, come la depressione respiratoria e la morte.
Negli USA, l’accesso incontrollato a questi farmaci ha portato ad una crisi socio-sanitaria, identificata con il nome di epidemia da oppiacei, con numerosi morti e gravi conseguenze per la salute. Ecco perché l’uso di queste sostanze ha bisogno di un controllo severo.
In Italia l’accesso ai farmaci più potenti avviene in strutture sanitarie chiamate centri per la terapia del dolore in ospedale o in specifici ambulatori, in cui il paziente viene trattato con i farmaci più appropriati al grado di dolore avvertito. Nel caso di dolore intenso ed invalidante come nel caso di chirurgie profonde o in pazienti oncologici, si utilizzano oppioidi potenti come la morfina e il fentanyl, o anche il più noto metadone, usato nei programmi di disassuefazione/disintossicazione da eroina.
Ci sono solo morfina e fentanyl per la terapia del dolore?
I farmaci della classe degli oppioidi sono certamente i più potenti analgesici conosciuti e la lista dei farmaci presenti in questa classe, utilizzabili nelle diverse situazioni richieste dalla terapia del dolore, è piuttosto nutrita. Si differenziano per potenza, durata d’azione, via di somministrazione e anche effetti collaterali.
Se prendiamo, ad esempio, il gruppo degli oppiacei (i derivati dell’oppio come la morfina), la ricerca è finalizzata a modificare la struttura chimica di base dei farmaci simbolo (per esempio la morfina), in modo da esaltare le proprietà antidolorifiche ed eliminare gli effetti indesiderati (ad esempio la depressione respiratoria e la stipsi).
Queste nuove molecole sono chiamate in inglese “biased-agonists”, e si caratterizzano per attivare esclusivamente i recettori che mediano l’attività analgesica. In pratica, queste nuove molecole funzionano come le chiavi elettroniche, che modificano l’accesso ad una porta (recettore) affinché non possa esser aperta al passaggio di persone non autorizzate (vie di segnale che inducono gli effetti collaterali).
Ci sono delle novità nella terapia del dolore, al di fuori degli oppiacei?
Assolutamente sì anche perché ci sono forme di dolore che hanno una grande diffusione nelle persone, quali ad esempio l’emicrania che caratterizza principalmente il sesso femminile ed è molto diffusa a livello mondiale. Ma gli oppioidi non sono indicati per il trattamento dell’emicrania.
Negli ultimi anni si è molto lavorato per identificare nuovi meccanismi e nuovi bersagli verso i quali indirizzare lo sviluppo di farmaci analgesici. Una possibilità è quella di bloccare le errate comunicazioni tra i neuroni responsabili della trasmissione del dolore, come succede nel maladattamento.
Inoltre, mentre si studiava l’attività di un recettore importante per la formazione dei nuovi vasi sanguigni, ci si è accorti che questo era coinvolto anche nel mantenimento del dolore neuropatico periferico e il suo blocco poteva avere effetti benefici.
Infine, adesso sappiamo che altre tipologie cellulari, oltre ai neuroni, sono coinvolte nella percezione del dolore, permettendo quindi di studiare sostanze capaci di modulare la loro attività e, di conseguenza, ampliare la scelta terapeutica.
Chi sono questi altri attori nella risposta al dolore?
L’attenzione dei ricercatori si è spostata anche sul ruolo dei processi infiammatori. Succede, infatti, che particolari tipi di cellule che prendono il nome di cellule gliali (astrociti e microglia), in alcune condizioni, possono rilasciare delle sostanze infiammatorie, provocando un’eccessiva stimolazione dei meccanismi di percezione del dolore in risposta a stimoli normalmente innocui. Ecco perché spegnere l’eccessiva risposta infiammatoria a questo livello potrebbe essere molto utile nella lotta al dolore.
E ci sono anche altre cellule che, con un meccanismo alternativo, entrano nella trasmissione del dolore Queste sono le cellule di Schwann che contribuiscono all’isolamento elettrico dei segnali trasmessi dai neuroni, raffreddando la percezione del dolore. Negli ultimi anni è stato scoperto che proprio in queste cellule è presente un canale ionico, chiamato TRPA1 (dall’inglese transient receptor potential-1), che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento del dolore neuropatico3 .
Cosa si può fare dal punto di vista farmacologico su questi canali?
I canali TRP sono dei trasformatori di segnali. Raccolgono gli stimoli chimici e/o fisici e li trasformano negli stimoli elettrici su cui si basa la trasmissione nervosa: in questo modo contribuiscono alla percezione del dolore. Ad esempio, il già citato TRPA1, un sensore dello stress ossidativo, è stimolato dal wasabi, la nota salsa piccante giapponese.
Al contrario, il mentolo lo attiva o lo inibisce a seconda della sua concentrazione. Uno di questi canali, il TRPV1, viene già usato come bersaglio nel trattamento farmacologico di alcune forme di dolore. TRPV1 è infatti sensibile alla capsaicina, la molecola che conferisce al peperoncino il tipico gusto piccante e la sensazione di calore.
È però curioso vedere come la capsaicina, permanendo a lungo sui bersagli (i recettori TRPV1 appunto) li spegne, limitando la trasmissione sia dell’irritazione causata dalla capsaicina che quella responsabile del dolore4 . La capsaicina si usa oggi per trattare la neuropatia diabetica periferica o la nevralgia post-erpetica (il cosiddetto “fuoco di Sant’ Antonio”).
Che si sa del dolore addominale e della sua terapia?
La gestione del dolore addominale rappresenta una esigenza terapeutica non soddisfatta dagli antidolorifici e neppure da quelli per il trattamento dei disordini intestinali. Il problema è che, in questo caso, oltre alle cellule nervose, l’intestino vede la presenza di una importante parte del nostro sistema immunitario che colloquia con il cervello attraverso quello che viene definito l’asse intestino-cervello il cui funzionamento è garantito anche dai microrganismi che compongono il microbiota intestinale.
Oggi c’è grande discussione sulle evidenze scientifiche che dimostrano il ruolo del sistema immunitario intestinale ed in particolare del microbiota, con cui le cellule del sistema immunitario colloquiano per mantenere l’equilibrio del nostro corpo, e della possibilità di effettuare la regolazione farmacologica del suo funzionamento. In particolare, trova molta attenzione la ricerca che dimostra la possibilità di trasferire «dolore» da un individuo all’altro mediante un trapianto di microbiota. Questi studi stanno aprendo le porte a trattamenti analgesici basati sull’utilizzo di trapianti fecali.
E del mal di testa, dell’emicrania, delle cefalee, si sa qualcosa sul loro trattamento?
Purtroppo, quello dell’emicrania è un problema al quale la farmacologia sta dando risposte solo molto di recente. Non stiamo parlando di un mal di testa occasionale ma di quella patologia che affligge milioni di persone, più frequente di sesso femminile, con cadenze cicliche, impedendo loro di avere una vita normale.
I farmaci in uso per la profilassi dell’emicrania, cioè per prevenire l’insorgenza della patologia non rappresentano la terapia ideale: questi sono gli antiepilettici, i beta-bloccanti, gli antidepressivi triciclici, la cui efficacia è spesso limitata mentre, al contrario, mostrano effetti collaterali che, molto spesso, inducono i pazienti a interrompere la terapia anche dopo poco tempo averla iniziata.
Però, qualcosa si sta muovendo anche per questa patologia.
Ci sono farmaci arrivati da poco ed altri in corso di sviluppo il cui bersaglio è una piccola proteina che deriva dal gene per la calcitonina (di nome CGRP, dall’inglese calcitonin gene related peptide). Questi farmaci, che neutralizzano il CGRP, sono sia piccole molecole di sintesi che anticorpi monoclonali, sui quali sono stati accumulati molti dati negli ultimi 15 anni, dimostrandone l’efficacia e sicurezza.
I più recenti sono quattro (galcanezumab, fremanezumab, eptinezumab e erenumab), per la profilassi dell’emicrania e della cefalea a grappolo, che prevedono una somministrazione sottocutanea o endovenosa una volta al mese o addirittura ogni tre mesi. In Italia attualmente sono in uso clinico galcanezumab, fremanezumab ed erenumab per la profilassi dell’emicrania.
È possibile trattare il dolore anche con estratti naturali?
Si, in effetti per alcuni estratti naturali è stata riconosciuta un’attività analgesica. Tra questi ricordiamo gli estratti di Harpagophytum procumbens (Artiglio del diavolo), della Boswellia serrata (incenso), della Curcuma longa, della Commiphora (mirra), del Capsicum annum e frutescens (peperoncino), del Zingiber officinalis (zenzero) e dell’Arnica montana.
Per alcuni è noto il meccanismo d’azione, come nel caso del già citato peperoncino. Per altri invece, definiti “sostanze complesse”, si riconosce più di un meccanismo che concorre all'effetto terapeutico. Ultimamente l’interesse scientifico si è spostato anche su questi estratti per il fatto che gli anziani, sicuramente parte della popolazione che più spesso deve ricorrere all’uso di farmaci analgesici, soffrono più facilmente gli eventi avversi dei farmaci per le terapie croniche. Per questo si studia la possibilità di usare degli estratti vegetali, in combinazione agli analgesici tradizionali, che potrebbero aiutare a ridurre i dosaggi di questi ultimi.
Come si colloca la cannabis terapeutica in questo panorama?
La cannabis terapeutica è la nuova frontiera della scienza che potrebbe dare vita ad una vera e propria svolta nella risoluzione di una lunga serie di problemi di salute, come il dolore cronico, quello spesso definito di tipo neuropatico, notoriamente difficile da trattare. Solo il 40-60% delle persone colpite riesce a trovare un sollievo parziale dei sintomi con gli antidolorifici “tradizionali”.
Di recente, uno studio canadese ha dimostrato che tre boccate di cannabis al giorno possono alleviare i dolori neuropatici. L’utilizzo della cannabis risulta efficace anche se utilizzata per applicazioni locali. Queste possono essere una strategia utile soprattutto per contrastare il dolore alla schiena. In un recente studio, pubblicato sulla rivista Journal of Opioid Management, l’applicazione locale di cannabidiolo (CBD, uno dei componenti della cannabis) ha alleviato sia il dolore acuto, in fratture da compressione lombare, sia il dolore toracico cronico, tra l’altro senza riscontrare effetti collaterali di sorta.
Di tutto questo si parlerà ampiamente nel corso di simposi, tavole rotonde e letture di esperti in occasione del prossimo 40° congresso nazionale della Società Italiana di Farmacologia che si terrà dal 9 al 13 marzo 2021.
Riferimenti bibliografici e sitografici:
1 Ministero della Salute – Cure Palliative e terapia del dolore
2 Position Paper della Società Italiana di Farmacologia “Trattamento del dolore cronico in Italia: appropriatezza terapeutica con oppiacei e timore di addiction: situazione italiana vs USA”. Diego Fornasari, Gilberto Gerra, Sabatino Maione, Guido Mannaioni, Alessandro Mugelli, Daniela Parolaro, Patrizia Romualdi e Paola Sacerdote
3 De Logu F. et al. Schwann cell TRPA1 mediates neuroinflammation that sustains macrophage-dependent neuropathic pain in mice Nature Communication. 2017 Dec 1;8(1):1887. doi: 10.1038/s41467-017-01739-2.
4 Chung M & Campbell J.N. Use of Capsaicin to Treat Pain: Mechanistic and Therapeutic Considerations. Pharmaceuticals (Basel). 2016 Nov 1;9(4):66. doi: 10.3390/ph9040066.